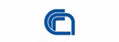La cucina italiana patrimonio Unesco: soltanto marketing?
di Nello Biscotti
- 17 December 2025
Si vogliono leggere in questo riconoscimento “Identità e Tradizione”, entrambe parole grosse dalle quali è opportuno partire. Pretendere di definire l’identità e imporla a ogni costo è un esercizio demagogico, perché essa – come ricorda l’antropologo Michael Herzfeld – è per sua natura multipla, mutevole e continuamente negoziata. Le retoriche identitarie, spesso strumentalizzate e apparentemente rassicuranti, possono essere profondamente pericolose, come sottolineano gli storici; per questo è necessario distinguerle, decostruirle e contrastare gli abusi conoscitivi che generano.
Usare poi l’identità come chiave di lettura della cucina è del tutto inappropriato: la cucina italiana, nei fatti, è plurale, mai fissa e in continuo divenire. Demagogia e retorica anche nella parola tradizione, spesso utilizzata per rafforzare un’idea di identità, ma che oggi finiamo per rispolverare più che trasmettere davvero. Nei fatti non tramandiamo più nulla, perché non c’è più niente da trasmettere: ciò che oggi chiamiamo tradizione è costruito su rievocazioni, nostalgie e memorie di un tempo che non c’è più da tempo e, per fortuna.
Già dagli anni Cinquanta del Novecento la gastronomia italiana si è fondata in larga misura su cibi industriali, attraverso i quali abbiamo soppiantato in breve tempo ogni consuetudine precedente, poiché ci ricordavano fame e miseria. Questa era la tradizione; infatti l’Unesco non la riconosce né la celebra. Ma quale tradizione, poi? Di quotidiane zuppe e minestre di verdure di ogni tipo? Quella degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, quando persino nei paesi più sperduti i negozi di generi alimentari (le drogherie) traboccavano di paste secche industriali, mortadelle, provoloni, galbanini e, come tocco finale, le immancabili scatolette di carne Simmenthal? E le scatolette di tonno o i barattoli di pomodoro e salse, con cui abbiamo mangiato la stessa pasta? Con drogherie e centri commerciali, abbiamo detto addio a quelle piccole tipicità locali che ora rimpiangiamo; abbiamo detto addio anche alla vera “cucina italiana”, che si esprimeva in un mosaico ricchissimo di tradizioni locali, oggi profondamente influenzato da tendenze tedesche, inglesi e americane.
L’America, più di qualunque altro Paese, continua a dettare le nostre abitudini alimentari. Si parla oggi di “Newstalgia”, le nuove nostalgie sul passato: la ricetta della nonna, l’orto del nonno, il vino del nonno, ecc., che non sfuggono a chi ha almeno 50 anni. Ma pure le nonne baravano: già negli anni ’60 e ’70 avevano fatto proprie le ricette stampate sulle etichette di tante confezioni alimentari, un po’ come oggi si seguono le riviste patinate che dispensano “ricette della tradizione”.
Il riconoscimento Unesco potrà certamente produrre benefici, ma non può che rafforzare soprattutto un marketing che continua a funzionare bene. È quindi facile immaginare una maggiore attrattività turistica in un Paese che, tuttavia, deve risolvere alcune criticità strutturali: da un lato l’overtourism, dall’altro un sistema che concentra le presenze turistiche su appena l’1% del territorio nazionale. A ciò si aggiunge l’incapacità di far emergere e valorizzare i molti “turismi” italiani, vecchi — enologico, enogastronomico — e nuovi, come quello delle DOP/IGP. Solo il 17,5% delle aziende vitivinicole offre attività di accoglienza enoturistica; il turismo delle DOP, inteso come incrocio tra enogastronomia, cultura e sostenibilità, vede in prima linea soltanto alcune regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, in particolare per formaggi e salumi), mentre nel resto d’Italia fatica ad affermarsi, anche a causa del mancato funzionamento dei consorzi di tutela cui è affidata la promozione delle denominazioni. E’ bene ribadire inoltre che il turismo sul cibo, e non solo, per quanto lo immaginiamo strategico, non farà mai rinascere da solo i tanti borghi e paesi in corso di spopolamento.
Il risultato del riconoscimento Unesco è politico, perché di natura politica è stata la candidatura: puntare, cioè, al riconoscimento della cucina italiana nel suo complesso. Il risultato c’è stato, ed è la prima volta che accade. Motivo di orgoglio? Si sono cercate radici identitarie laddove la ricerca storica e antropologica — non da oggi — ha dimostrato che la cucina italiana, come ci ha insegnato lo storico Massimo Montanari, è sempre stata un arcipelago di culture locali, segnate da migrazioni, scambi e ibridazioni. È dunque antistorico, oltre che concettualmente incoerente, immaginare “un gusto e una tradizione nazionale in cui tutte le cucine locali fanno parte di un’unica grande cultura”, come afferma Alberto Grandi, storico dell’economia dell’alimentazione, in un suo podcast. Lo stesso Pellegrino Artusi, icona storica della cucina italiana, sosteneva che, pur essendo la ricetta legata a un territorio, essa è sempre il risultato di adattamenti. Del resto, nelle indagini sul cibo come patrimonio emerge come, in Europa, molte cosiddette “tradizioni alimentari” siano il prodotto di processi di costruzione culturale — nazionalizzazioni, politiche identitarie, strategie di marketing — più che lasciti intatti del passato. Analoghe valutazioni emergono anche da studi su scala globale, che rilevano la natura intrinsecamente instabile e ibrida dei sistemi gastronomici, dovuta alla costante interazione e contaminazione delle pratiche alimentari.
Questo riconoscimento rischia di trasformarsi in un’operazione di marketing più che in un impegno strutturale a proteggere paesaggi e trasmettere pratiche, saperi e riti della nostra cucina. Con questo riconoscimento si potrebbe cercare di dare il necessario spessore culturale che manca nella nostra narrazione enogastronomica. E qui è opportuno chiarire un po’ il senso di questo riconoscimento Unesco, che in fondo legittima istituzionalmente un patrimonio culturale mobile, fondato su pratiche condivise e in continua rielaborazione. E in questo siamo stati molto bravi, forse persino unici. È questo che dobbiamo saper valorizzare nel mondo grazie al riconoscimento Unesco, che premia nella sostanza il particolare rapporto degli italiani con il cibo. Perché unisce le persone attraverso la pratica del cucinare e del mangiare insieme; coinvolge pratiche sociali, conoscenze e rappresentazioni; fa parte del vissuto culturale delle comunità, che continuano a trasmetterlo nel tempo.
Il riconoscimento non riguarda quindi, e in alcun modo, il valore gastronomico di ricette, piatti o ingredienti, nessuno dei quali è insostituibile, né gusti o sapori, né implica l’attribuzione di un primato culinario. Non emerge alcun tratto identitario; al contrario, dalle motivazioni dell’Unesco risulta evidente che il riconoscimento valorizza la pluralità e la diversità delle pratiche culinarie. Gli storici non da oggi ci hanno spiegato che la cucina italiana non possa essere assunta come repertorio codificato, ma come insieme di pratiche e saperi quotidiani, fondati sulla convivialità, sulla stagionalità e sulla dimensione domestica del cibo, che oggi, a dire il vero, non c’è quasi più, poiché sempre più famiglie vanno al ristorante. La tradizione è tutt'altro.
Potrà dare dignità alla pluralità delle tradizioni regionali e locali italiane solo se saremo in grado di scrivere veri racconti, a partire da quelli di un cibo legato a un’Italia che continua a resistere: quella dei contadini “eroici”, di vecchie vigne e frutteti che ancora disegnano le aree interne del Paese, ma anche delle cascine e delle case rurali che crollano, delle campagne abbandonate che qualcuno dovrà pur spiegare. Abbiamo già l’esperienza della Dieta Mediterranea, altro nostro patrimonio Unesco, che nei fatti è poco praticata ma continua a funzionare solo sul piano del marketing. I tassi di obesità e l’aumento delle malattie, soprattutto nel Sud dove questa dieta è nata, indicano chiaramente che in Italia essa è seguita da pochi, mentre ispira molto di più nei Paesi esteri. Il rischio è realmente quello di una sua semplificazione, dovuta all’incapacità di attribuire spessore — ripeto, culturale — alle nostre narrazioni, come già è accaduto per la Dieta Mediterranea, ridotta a un ricettario. In realtà, essa ha prodotto una quantità infinita di ingredienti e preparazioni culinarie, motivate dalla fame costante. Queste invenzioni sono state possibili perché i nostri “padri” hanno saputo muoversi in ambienti molteplici e indefiniti dell’Italia collinare, montana e persino palustre. In questo senso, il Tavoliere delle Puglie ha molto da raccontare. In questo risiede il valore, unico della nostra “cucina” che può definirsi “italica”, perchè legata alla varietà dei territori, degli ambienti ecologici di questa lunga penisola, esposta ai mari, attraversata da Alpi e Appennini, e fatta anche di pianure.