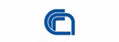Cibi e bevande in casa Medici
Dopo la morte del Magnifico, distrutto a quarantatre anni proprio da quella alimentazione ricca di carni saporite e povera di verdure, i cupi anni savonaroliani fecero scomparire il gusto della buona tavola..
di Giovanni Cipriani
- 01 February 2023
Ultimi inserimenti
- Ai Georgofili la lectio magistralis del Nobel Myerson: la politica locale è stata una parte essenziale della vita umana fin da molto prima della prima istituzione di Stati estesi
- BUONE FESTE
- "Notizie Forestali" - Gestione Forestale Sostenibile: un evento in tre fasi sostenuto dall’Accademia dei Georgofili
- Perché scegliere Agraria all’Università
- Coltivare caffè in Sicilia: dalla sperimentazione alla costruzione di un modello agronomico mediterraneo
Nel 1444 prendeva forma concreta il palazzo mediceo di Via Larga. Cosimo il Vecchio aveva commissionato a Michelozzo una superba dimora, ricca di ambienti per ogni necessità, specchio dello stile di vita di un grande finanziere, nelle cui mani si trovava in larga misura anche la vita politica dello stato fiorentino. Il palazzo divenne celebre per fasto e raffinatezza. I suoi arredi erano sontuosi e fra le sue mura spiccava la splendida cappella privata che Benozzo Gozzoli aveva impreziosito di affreschi colmi di luce, dedicati ai Re Magi ed al loro viaggio avventuroso per rendere omaggio al piccolo Gesù.
Cosimo il Vecchio e sua moglie, Contessina dei Bardi, allestivano spesso ricchi conviti, facendo tesoro dei prodotti che dalle loro fattorie mugellane del Trebbio e di Cafaggiolo, giungevano costantemente in città. Contessina era famosa per la cura e la disponibilità con cui accoglieva i propri ospiti.
Quando in casa Medici iniziavano i preparativi per un incontro conviviale, dagli armadi della guardaroba venivano tolte “le più fini mutature da tavola”. Si consegnavano ai servitori le “tovagline di rensa”, che dovevano tenere sul braccio porgendo le vivande, i “servietti” per asciugare le mani dei convitati dopo le consuete abluzioni e le tovaglie da stendere sulle credenze.
Da altri armadi venivano tratte le stoviglie e le più fini argenterie. Le “confectiere d’ariento col coperchio et bechuccio”, i taglieri di legno, i tondi di stagno, le “posate d’ariento”, le tazze “bollate alla Parigina”, il grande catino “da gelatina”, gli oggetti di “porciellana e piattelli, schodelle, schodellini di terra lavorata a Montelupo”, rendevano splendida la sala del convito.
In cucina ferveva l’opera dei cuochi. Accanto al pesce marino si trovavano in quantità lamprede dell’Ombrone, trote e lucci, per non parlare di fagiani, starne, anatre e polli che, assieme a volatili più minuti, venivano preparati per l’arrosto. Sul fuoco già giravano agnelli, capretti, cosci di vitella e di “porcho selvatico”, accompagnati, nel loro moto, da periodiche spennellature d’olio d’oliva per non disseccarne eccessivamente le carni. “Teghie” e “teghami” ospitavano “guazzetti e savori”, inumiditi con vino bianco e con agresto. Da padelle fumanti venivano fatti emergere “tomacelli” croccanti e dorati mentre i ravioli, distesi sulle stuoie erano pronti per essere immersi nel brodo che bolliva in pentole di rame stagnato.
Tutto veniva preparato con cura e nella sala, prima dell’arrivo degli ospiti, si controllava se “piattelli, schodelle e schodellini” fossero di quelli “da padroni”, se i “chandeglieri” fossero stati ben disposti, se “l’infreschatoio di diaspro legato in ariento” fosse stato riempito di acqua fresca, se nello “schaldavivande d’ottone” si trovasse brace in giusta quantità, se le “chonfecterie” fossero guarnite di “treggea, confetti e morselletti”, se, al posto di ogni scalco, fossero stati preparati i “chucchiai da scommettere, le choltegliere e un tovagliolino da choltelli” per asciugarli dopo aver tagliato l’arrosto, se tutte le “acquiere”, comprese le due “parigine” e le due “vignonesi”, fossero state collocate, accanto ai grandi fiaschi “d’ariento e di stagno”, se le “saliere d’ariento” e il “bossolo da spetie” si trovassero nei luoghi opportuni, a disposizione dei commensali.
Galeazzo Maria Sforza, ospite di Cosimo e di Contessina nel 1459, rimase colpito dalla squisita accoglienza medicea e dalla ricchezza di una casa davvero non comune. Pietanze prelibate e ottimi vini lo accompagnarono ovunque, a Firenze, a Cafaggiolo, a Careggi e
“Sì copiosamente ebbe abbondare
Sì d’ogni cibo grazioso e buono
Che nullo seppe d’altro dimandare”.
Piero de’ Medici non fu da meno del padre nell’onorare il figlio primogenito del Duca di Milano:
“Le tavole per tutto ben fornite
fur di vivande d’ogni mandigione
…………………………………
A quel convito vi fu interamente
Ciò che sa dimandare il corpo umano”.
L’erede della grande fortuna di Cosimo il Vecchio era però già gravemente malato per i disordini alimentari che spesso, nelle maggiori famiglie, erano il riflesso in negativo della più sfrontata opulenza e la fama di “gottoso” lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Anche suo fratello Giovanni non “si guardava dalla bocca”, come gli raccomandava Contessina e, pur frequentando i bagni di Morba e Petriolo, ricchi di acque sulfuree che, con il loro calore naturale, sembravano curare le articolazioni gonfie e doloranti per i cristalli di acido urico, continuava a godere di “pinocchiati, berlingozzi e marzapani”.
Giovanni, incapace di frenare la propria ghiottoneria, morì il 1 Novembre 1463 e, a breve distanza, anche suo padre Cosimo scomparve, distrutto dal dolore. Tutte le speranze erano concentrate su Lorenzo, figlio primogenito di Piero il Gottoso, che mostrava un ingegno poliedrico e vivace. Le sue nozze con Clarice Orsini, nel Giugno 1469, furono accompagnate da festeggiamenti di incredibile sfarzo ed anche sotto il profilo gastronomico si raggiunsero vette al di là di ogni immaginazione.
Tutti i Fiorentini dovevano partecipare alla gioia dei Medici che, dopo tanta tristezza, vedevano la vita tornare ad affacciarsi nella propria famiglia, e Lorenzo fu abilissimo nel rendere la propria figura di estrema popolarità con generose elargizioni.
Racconta Piero Parenti che il 2 Giugno 1469 giunsero dal contado la gran parte dei doni per gli sposi e che in Piazza San Lorenzo, non lontano dal Palazzo di Via Larga, “furono portati centocinquanta vitelli, duemila paia di volatili, fra capponi, paperi e pollastri, pesci marini e trote in grande quantità, confetti assai, treggea grossa come corbezzole, mandorle, pinocchi e confetti contraffatti”. Di vino giunsero “parecchie some” e “botti intere di malvagia, trebbiano, vermigli e vini forestieri”.
I vitelli furono macellati con rapidità e Lorenzo volle che fossero donati a circa ottocento Fiorentini pezzi di carne da dieci a venti libbre di peso perché trionfasse la gioia e l’abbondanza. Subito dopo la cerimonia nuziale, Palazzo Medici accolse gli ospiti con il primo ricco convito. “Nell’orto sotto la loggia e da lato … erano ordinate le tavole e la sposa fu fatta sedere …. Nelle loggie che circondavano la corte di casa mangiavano e cittadini convitati”. Alle prime tavole erano sedute circa duecento persone ed i cibi giungevano con una elaborata coreografia. “Ciascuna vivanda veniva per la porta da via colle trombe innanzi … e i servitori volgevano a marritta delle logge e ritornavano a piè della scala … in modo che a un tratto le vivande si posavano in ogni luogo”.
Gli scalchi lavoravano incessantemente per tagliare le carni fumanti. “Erano misurati i piattelli secondo le tavole e fra quelli che li portava tramezzavano gli scalchi che guidavano quest’ordine e ciascuno guidava i suoi”. La lista delle vivande per i conviti della domenica e del lunedì comprendeva, per la mattina: “prima il morselletto, poi un lesso, poi un arrosto, poi cialdoni, marzapane, mandorle e pinocchi e poi le confettiere con pinocchiati e zuccate confette e la sera, per cena, gelatina, uno arrosto, frittellette, cialdoni e confetture”. Il martedì mattina, “in scambio del lesso, erbolati col zucchero in su taglieri”.
Non mancavano vini eccellenti, che abbiamo visto giungere a botti: “malvasia trebbiano e vermigli ricchi di sapore”. Per combattere il caldo dell’estate tutte le bevande venivano rinfrescate nel modo più semplice ed elegante. “Niuna credenziera vi era ordinata per arienti, solo deschi alti nel mezzo della corte … apparecchiati di tovaglie e in su’ quattro canti, quattro bacini d’ottone grandi per bicchieri e dietro a questi deschi stavano gente ad amministrare vino e acqua … In sulla tavola era tra due una tazza grande d’ariento, piena d’acqua fresca, dove si mettevano i bicchieri del vino e dell’acqua in fresco. Eranvi saliere d’ariento, forchette e coltelliere, nappi pe’ morselletti e mandorle confette e confettiere pe’ pinocchiati”.
Il lunedì mattina, Lorenzo volle che a molti Fiorentini fosse distribuita della gelatina, “insino al numero di circa millecinquecento taglieri” e offrì alla gran parte dei religiosi presenti nei conventi della città: “polli, pesci, confetti, vino”. Oltre che nel Palazzo Medici, era stato allestito un ricco convito “nella casa di messer Carlo di Cosimo”, dove “si beea ogni dì più che cento barili di vino”.
Lorenzo amava ogni piacere e quello della tavola era uno dei più immediati e costanti. Tra le specialità fiorentine il Magnifico adorava i cialdoni ed in tempo di Carnevale non mancava di gustarli con partecipazione. Lui stesso era espertissimo nel maneggiare i ferri per realizzarli, come ci fa comprendere in uno dei suoi Canti Carnascialeschi:
“Giovani, siam maestri molto buoni
Donne com’udirete a far cialdoni
……………………………………
Non eran prima fatti che mangiati
Da noi che ghiotti siam tutti i cialdoni
……………………………………
E insegneremvi come si fan buoni.
Metti nel vaso acqua e farina dentro
Quanta ve n’entra e mena a compimento
Quand’hai menato ei vien come un unguento
Un’acqua quasi par di maccheroni.
Chi non vuole al menar presto esser stanco
Meni col dritto e non col braccio manco.
Poi vi si getta quel ch’è dolce e bianco
Zucchero e fa ‘l menar non abbandoni
…………………………………….
Fatto l’intriso poi col dito assaggia
Se ti par buon le forme al fuoco poni
Scaldale bene e se la forma è nuova
Il fare adagio e ugner molto giova.
……………………………………..
Quando lo ‘ntriso nelle forme metti
E senti frigger tieni i ferri stretti
Mena le forme e scuoti acciò s’assetti.
Volgi sossopra e sien ben cotti e buoni
………………………………………….
Quando e ti par che sia fatto abbastanza
Apri le forme e cavane i cialdoni
……………………………………..
Se son ben cotti, coloriti e rossi
Son belli e quant’un vuol mangiarne puossi”.
Lorenzo, ghiotto di selvaggina, si recava spesso a Lecore dall’amico Ugolino Verino “per gustare arrosti di ortolani e tordi” e persino la moglie, Clarice Orsini, per fargli cosa gradita, quando soggiornava nella villa di Cafaggiolo e Lorenzo si tratteneva a Firenze, gli inviava gli animali selvatici più saporiti. “Mandovi queste dua lepri le quali, questa mattina a buona hora, prese la Turcha, acciocché per mio amore con esse di me … vi ricordiate”.
Anche i formaggi erano cari al Magnifico e la zona di Poggio a Caiano, dove si era fatto costruire una splendida villa, su progetto di Giuliano da San Gallo, offriva ottimi pecorini e “chaci vaccini”, per i verdi pascoli che la caratterizzavano. Il poeta Ugolino Verino, sempre sensibile ai buoni cibi, non mancava di sottolinearlo, ricordando che proprio Lorenzo aveva fatto giungere nelle campagne attorno a Firenze mucche di ogni razza.
“A tempi nostri, alla diligenza
Dei Medici, le vacche fur condotte
Dai paesi stranieri nel vicino
Poggio a Caiano ai freschi e lieti pascoli
E di quivi in città pingui formaggi”.
Con gli scarti di lavorazione venivano allevati grassi maiali in una “chascina” presso “Sancta Maria a Bonistallo”, non troppo lontano dalla sontuosa villa Medici ed anche le loro carni venivano utilizzate per arrosti, prosciutti e per ricavare lardo, allora tanto usato come conservante e per cuocere cibi al posto dell’olio.
Fra i letterati amici del Magnifico spiccava, per il suo amore per la tavola, Luigi Pulci. Nel Morgante egli fa recitare a Margutte un singolare “credo” che certamente veniva condiviso da molti degli allegri commensali di casa Medici:
“Io non credo più al nero ch’all’azzurro
Ma nel cappone, o lesso o vuogli arrosto
E credo alcuna volta anco nel burro
Nella cervogia e, quando io n’ho, nel mosto
E molto più nell’aspro che il mangurro.
Ma sopra tutto nel buon vino ho fede
E credo che sia salvo chi gli crede
E credo nella torta e nel tortello
L’uno è la madre e l’altro è il suo figliuolo
Il vero paternostro è il fegatello
E possono essere tre, due ed uno solo”.
Anche Matteo Franco non era da meno e con i suoi versi criticava aspramente i cibi che erano risultati sgradevoli al suo finissimo palato:
"No’ andammo jer, Lorenzo, a un convito
………………………………………..
Timido aceto avemmo et olio ardito
Insalata anzi sciocca, passa e dura
Pan che facea salnitro per le mura
Vin vecchio tondo, quadro e rimbambito
Battezzaron pippion due colombelle
Che bolliron dell’ore ben diciotto
Poi furon per fuggir dalle scodelle”.
Poco dopo la morte del Magnifico, distrutto a quarantatre anni proprio da quella alimentazione ricca di carni saporite e povera di verdure, i cupi anni savonaroliani fecero scomparire il gusto della buona tavola. L’invito a digiuni e a penitenze allontanava del tutto l’uricemia, ma faceva venir meno anche uno dei grandi piaceri della vita, confinato irrimediabilmente nell’esecrabile peccato della gola.