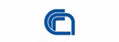La cucina del solstizio di inverno
di Giovanni Ballarini
- 18 December 2019
Ultimi inserimenti
- Ai Georgofili la lectio magistralis del Nobel Myerson: la politica locale è stata una parte essenziale della vita umana fin da molto prima della prima istituzione di Stati estesi
- BUONE FESTE
- "Notizie Forestali" - Gestione Forestale Sostenibile: un evento in tre fasi sostenuto dall’Accademia dei Georgofili
- Perché scegliere Agraria all’Università
- Coltivare caffè in Sicilia: dalla sperimentazione alla costruzione di un modello agronomico mediterraneo
Nell’antico pensiero di un tempo circolare nel quale solstizi e equinozi scandivano le produzioni agricole e la disponibilità degli alimenti anche la cucina era regolata da tradizioni che marcavano i singoli periodi dell’anno in relazione ai ritmi circadiani di luce – buio e alle condizioni climatiche. Oggi tutto questo è in gran parte perduto e nelle società urbane e industriali dominate da un tempo lineare la popolazione vive in ambienti climatizzati con ritmi luce – buio artificiali e in ogni periodo dell’anno si trovano sempre gli stessi alimenti, mentre le tradizioni di tempo circolare sono sostituite da campagne pubblicitarie che tendono a destagionalizzare l’uso degli alimenti e quindi anche la cucina.
Particolarmente importante era il solstizio d’inverno quando il sole che continua a calare e sembra morire inizia a risorgere e bisogna festeggiar-ne l’evento con riti anche alimentari che si perdono nella notte dei tempi, ma dei quali abbiamo testimonianza nelle celebrazioni romane del Sol Invictus. Da qui l’atmosfera festosa che nell'Urbe antica regnava dal 17 al 23 dicembre quando si svolgevano i Saturnali, feste durante le quali si voleva far rivivere il regno di Saturno, l'età dell'oro, epoca di eguaglianza e di abbondanza. Agli inizi la festa durava un solo giorno, il 26 dicembre, ma Augusto stabilì che i giorni fossero tre, poi il periodo si allungò ancora. Durante le feste dedicate al dio nel mese di dicembre si usava tra i cittadini uno scambio di doni e di candele, simbolo della luce di civiltà che Saturno ave-va introdotto. Feste di solstizio che la nuova religione cristiana trasformò nel Natale di Cristo, nuovo sole di salvezza. In questo cambiamento anche taluni alimenti e soprattutto alcune preparazioni culinarie divengono marca-tori di tempi passati e di riti dei quali dai più si è perso il valore simbolico, come è il caso tra i tanti del capitone della vigilia di Natale, delle paste in brodo e dei lessi del giorno di Natale, dello zampone o cotechino di capo-danno e della frutta secca.
Con l’inizio di novembre terminano i raccolti e i lavori nei campi e per superare l’inverno bisogna ridurre il numero degli animali che arriveranno alla primavera. La gallina che ha già prodotto molte uova e qualche galletto castrato e trasformato in cappone, la mucca o il bue anziani e soprattutto il maiale sono ingrassati con l’ultimo raccolto per essere macellati in coincidenza del solstizio invernale. Le carni di animali anziani come la gallina vecchia o il cappone e di animali che hanno lungamente lavorato come il bue o la mucca sono adatte solo a lunghe bolliture dalle quali ottenere brodi per cuocere paste ripiene e lessi da portare sulle tavole natalizie assieme a salse aromatiche come quelle di prezzemolo o piccanti di rafano. Ogni festa è preparata da un’attesa o veglia nella quale sono assenti i cibi della festività mentre sono presenti i vegetali e soprattutto i pesci tra i quali il più ambito è l’anguilla cotta e conservata con l’aceto, soprattutto la femmina di grande taglia o capitone.
Un antico proverbio dice che lavandosi i piedi si sta bene un giorno, sposandosi un mese e sacrificando il maiale un anno. Il sacrificio del maiale – tradizionalmente tra il 13 dicembre S. Lucia e il 17 gennaio S. Antonio Abate – è seguito da un attento e intelligente lavoro dei norcini o mazén che trasformano le carni e i grassi dell’animale in prodotti da consumare dopo qualche settimana, uno o più mesi o più stagioni superando anche uno o più anni. Parti del maiale di non facile conservazione come la pelle, ben tritata e miscelata con carne e grasso dell’animale, è trasformata in cotechini, zamponi e altri insaccati che devono essere rapidamente consumati e compaiono nella cena dell’ultimo dell’anno o del pranzo di capodanno. Per lo stesso motivo le ossa del maiale sono destinate alla produzione del brodo che con le verze fa parte della cena che conclude il sacrificio dell’animale.
Con l’autunno non vi è più frutta fresca che è sostituita da frutta secca locale o d’importazione secondo le possibilità economiche. Fin dal tempo degli antichi Romani la frutta secca è un simbolo ben augurante, in particolare quella dal guscio duro e dall’interno morbido come mandorle, noci e nocciole che in seguito divengono simboli cristiani di interiorità e di misticismo. Da qui anche i tipi di frutta che si dovrebbero mangiare con predilezione dei numeri primi 13, 7 o almeno 3, comprendendo noci, nocciole, mandorle, arachidi, uvetta, fichi e datteri. Per chi può non manca l’uva passita e fin dal Rinascimento alla frutta secca s’accompagna quella candita o la melagrana che già per la mitologia greca e romana era sacra a Giunone e a Venere e quindi simbolo di fertilità e ricchezza. Nel passato sulle tavole dell’Italia centro-settentrionale dalla Sicilia arrivavano anche gli agrumi e soprattutto i mandarini.