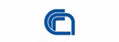Sarà la cannabis a salvare Taranto dal disastro ambientale dell’Ilva?
- 22 June 2016
Ultimi inserimenti
- Premio Soldera Case Basse edizione 2026
- "Notizie Forestali" - Alberi micorrizati e tartufi: uno spunto dalla Croazia per riflettere sul futuro italiano
- Cucina di oggi: una bella confusione!
- L’alta acidità dell’olio non dipende solo dalla mosca olearia
- Alberi in città: scienza, conoscenza e coscienza per una gestione sistematica e sistemica
Il libeccio soffia lieve. Fino a qualche anno fa portava nubi rosse, cariche di polvere di ferro. Oggi non più: l’aria è cambiata, odora di mare. La terra invece no, è ancora inquinata dalla diossina. Sul campo della masseria la cannabis cresce sotto il sole d’inizio giugno. Le piante sono alte un metro e mezzo. L’agricoltore punta gli occhi scuri verso le ciminiere dell’Ilva. Dice: «Eccolo il mostro che ci avvelena. Speriamo che la canapa lo circondi e lo soffochi, proprio come fa con le erbe infestanti».
A due chilometri in linea d’aria c’è la più grande acciaieria d’Europa. Un gigante di tubi, altiforni, lamiere, nastri trasportatori e parchi minerali su 15 milioni di metri quadrati. È grande una volta e mezza Taranto. Nel regno del ferro il dominio è delle macchine. L’uomo è residuale, minuto, insignificante. Eppure questa storia è la rivincita dell’uomo. Anzi, di due fratelli: Vincenzo e Vittorio Fornaro. Famiglia tarantina, stirpe contadina, allevatori da tra generazioni. Fino al dicembre 2008, quando la Regione ordina di abbattere le loro 600 pecore perché contaminate dalla diossina dell’Ilva. «È stato il giorno più brutto della mia vita. Quella sera in masseria c’era un silenzio assordante. Eravamo abituati ad addormentarci con il suono del bestiame», racconta Vincenzo. «Il bivio era: andarcene e ricominciare da un’altra parte o rimanere e combattere». Otto anni dopo i Fornaro sono ancora qui. Hanno appeso tre campanacci alla porta della masseria: «Ci ricordano le pecore». Oggi la litania è suonata dal vento.
Le carcasse degli animali, le lacrime, la rabbia, il divieto di pascolo nel raggio di 20 chilometri dalla zona industriale. Sembrava finita. E invece era l’inizio della seconda vita dei Fornaro. L’intuizione giusta arriva dai ragazzi dell’associazione «CanaPuglia»: convertire i terreni alla cannabis per decontaminare i campi. L’allevatore accetta la sfida e riparte dall’unica certezza che gli resta: l’amore per la sua terra. La prima semina avviene nel 2014, circondata da scetticismo. «Sapevo poco della canapa, non è stato facile», racconta Vincenzo. Ma la salute del terreno migliora. Rispuntano erbe selvatiche. Dopo un anno di pausa, due mesi fa, l’ex famiglia di allevatori è tornata a spargere semi di cannabis.
In principio fu Chernobyl. A fine anni Novanta una società americana specializzata in biotecnologia ambientale coltiva canapa per decontaminare i terreni radioattivi zuppi di cesio, plutonio, piombo. Funziona. Sono una decina le piante in grado di svolgere questa funzione, dal girasole al pioppo. Le radici della cannabis si rivelano particolarmente adatte a bonificare i terreni avvelenati dalla diossina. In Italia si inizia a parlare di fitorisanamento nei primi anni Duemila. Partono progetti sperimentali. L’iniziativa più avanzata è quella di Taranto. «È un’operazione di bonifica a bassissimo costo rispetto a quelle tradizionali. Ma per i risultati scientifici serve tempo», spiega Marcello Colao, ingegnere dell’Associazione biologi ambientalisti pugliesi. I Fornaro hanno fatto da apripista, altri agricoltori sono pronti a seguire il loro esempio. E ora il sogno si fa più ambizioso: creare una cintura verde di cannabis attorno all’Ilva.
Conviene sgombrare il campo da equivoci: è tutto legale. La cannabis sativa non è una droga. Il Thc è nel limite dello 0,2% consentito dalla legge. Niente principio attivo, niente sballo. Gli usi sono molteplici, dal tessile alla bioedilizia. Il progetto si chiama «Green». L’obiettivo immediato è ripulire i terreni dalla diossina, quello a medio termine creare una filiera. «Taranto può diventare il distretto della canapa del Sud Italia», spiega Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Puglia. «È una coltura rustica che non ha particolari pretese nutrizionali. Diversi imprenditori locali sono pronti a convertirsi alla cannabis». Ma dovranno farlo senza l’aiuto della Regione: «I fondi comunitari all’agricoltura sono destinati per la produzione alimentare», frena l’assessore Leonardo Di Gioia.
Da: La Stampa 03/06/2016
A due chilometri in linea d’aria c’è la più grande acciaieria d’Europa. Un gigante di tubi, altiforni, lamiere, nastri trasportatori e parchi minerali su 15 milioni di metri quadrati. È grande una volta e mezza Taranto. Nel regno del ferro il dominio è delle macchine. L’uomo è residuale, minuto, insignificante. Eppure questa storia è la rivincita dell’uomo. Anzi, di due fratelli: Vincenzo e Vittorio Fornaro. Famiglia tarantina, stirpe contadina, allevatori da tra generazioni. Fino al dicembre 2008, quando la Regione ordina di abbattere le loro 600 pecore perché contaminate dalla diossina dell’Ilva. «È stato il giorno più brutto della mia vita. Quella sera in masseria c’era un silenzio assordante. Eravamo abituati ad addormentarci con il suono del bestiame», racconta Vincenzo. «Il bivio era: andarcene e ricominciare da un’altra parte o rimanere e combattere». Otto anni dopo i Fornaro sono ancora qui. Hanno appeso tre campanacci alla porta della masseria: «Ci ricordano le pecore». Oggi la litania è suonata dal vento.
Le carcasse degli animali, le lacrime, la rabbia, il divieto di pascolo nel raggio di 20 chilometri dalla zona industriale. Sembrava finita. E invece era l’inizio della seconda vita dei Fornaro. L’intuizione giusta arriva dai ragazzi dell’associazione «CanaPuglia»: convertire i terreni alla cannabis per decontaminare i campi. L’allevatore accetta la sfida e riparte dall’unica certezza che gli resta: l’amore per la sua terra. La prima semina avviene nel 2014, circondata da scetticismo. «Sapevo poco della canapa, non è stato facile», racconta Vincenzo. Ma la salute del terreno migliora. Rispuntano erbe selvatiche. Dopo un anno di pausa, due mesi fa, l’ex famiglia di allevatori è tornata a spargere semi di cannabis.
In principio fu Chernobyl. A fine anni Novanta una società americana specializzata in biotecnologia ambientale coltiva canapa per decontaminare i terreni radioattivi zuppi di cesio, plutonio, piombo. Funziona. Sono una decina le piante in grado di svolgere questa funzione, dal girasole al pioppo. Le radici della cannabis si rivelano particolarmente adatte a bonificare i terreni avvelenati dalla diossina. In Italia si inizia a parlare di fitorisanamento nei primi anni Duemila. Partono progetti sperimentali. L’iniziativa più avanzata è quella di Taranto. «È un’operazione di bonifica a bassissimo costo rispetto a quelle tradizionali. Ma per i risultati scientifici serve tempo», spiega Marcello Colao, ingegnere dell’Associazione biologi ambientalisti pugliesi. I Fornaro hanno fatto da apripista, altri agricoltori sono pronti a seguire il loro esempio. E ora il sogno si fa più ambizioso: creare una cintura verde di cannabis attorno all’Ilva.
Conviene sgombrare il campo da equivoci: è tutto legale. La cannabis sativa non è una droga. Il Thc è nel limite dello 0,2% consentito dalla legge. Niente principio attivo, niente sballo. Gli usi sono molteplici, dal tessile alla bioedilizia. Il progetto si chiama «Green». L’obiettivo immediato è ripulire i terreni dalla diossina, quello a medio termine creare una filiera. «Taranto può diventare il distretto della canapa del Sud Italia», spiega Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Puglia. «È una coltura rustica che non ha particolari pretese nutrizionali. Diversi imprenditori locali sono pronti a convertirsi alla cannabis». Ma dovranno farlo senza l’aiuto della Regione: «I fondi comunitari all’agricoltura sono destinati per la produzione alimentare», frena l’assessore Leonardo Di Gioia.
Da: La Stampa 03/06/2016